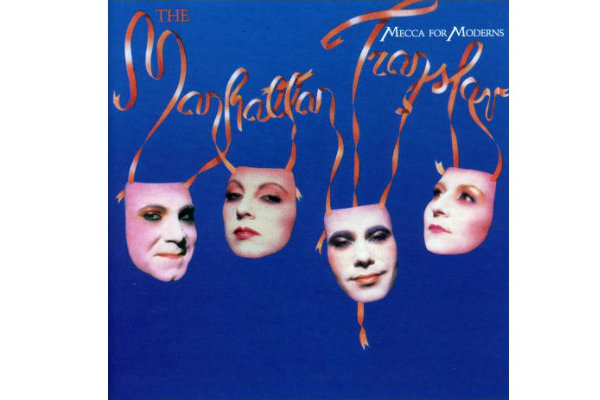Ieri sono andato a fare un giro a Enopoli, a Monteporzio Catone, annuale evento organizzato dal distributore.
Non sono rimasto molto, giusto la mattina, un paio d’ore direi, sufficienti per fare un rapido giro di assaggi di alcune etichette, dando priorità alle cantine del Lazio.
Buoni prodotti, tecnicamente, ma poco di veramente appassionante. Il vino, si sa, va venduto, i ristoratori soprattutto tendono a comprare e mettere in carta i vini più semplici, visto che altrimenti dovrebbero mettersi lì a spiegarli.
Certo mi risulta difficile capire perché una azienda, che usa trebbiano verde nei propri blend con la malvasia puntinata, spiegando che questo vitigno è originario proprio dalle campagne laziali ed imparentato con il verdicchio marchigiano, vada ad usare lieviti selezionati comprati in Sudafrica. Sottolineando inoltre che loro usano pochissima solforosa.
Il discorso sulla solforosa non l’ho iniziato io, il produttore ha solo risposto alla mia domanda sui lieviti, se indigeni o acquistati. Ed ha approfittato dicendo che il suo vino lo fa il Famoso Enologo; il quale decide quali lieviti usare, quali blend costruire, cosa aggiungere o togliere dal vino per renderlo adeguato alla Sua Fama. A questo punto, perché il produttore parla del ‘suo’ vino? In realtà è il ‘vino dell’enologo’ (semi cit.), il produttore è solo il proprietario delle vigne.
I vini sono tecnicamente discreti, ben fatti certo, ma non si fanno ricordare. La ricerca dell’equilibrio, la sapidità e la morbidezza tali che vanno bene quasi con qualunque piatto, lo rendono un prodotto fatto su ordinazione, un po’ freddo direi, senza molta anima. E la differenza fra le tre etichette assaggiate (Malvasia Puntinata e Verdicchio la prima, Falanghina e Malvasia Puntinata la seconda, qualcos’altro la terza) era davvero minima.
Ma io non faccio il ristoratore, non so cosa si venda e cosa vogliano bere i clienti, quindi magari fanno bene loro.
A me, non ha detto proprio niente, quel vino.
Un paio di aziende mi sono piaciute, una mi ha un po’ deluso, ma magari (beneficio del dubbio) non era l’occasione adatta per assaggiare i suoi vini.
La prima è L’Olivella, azienda che storicamente è legata ad Enopoli, visto che la prima sede della fiera si svolgeva nell’agriturismo dell’azienda.
Ho assaggiato tre belle bottiglie, tre vini ognuno con una bella ampiezza olfattiva, sensazioni diverse tra loro e piacevoli. Gli assaggi sono stati: il Bombino bianco 2012, gradevole, basilare, morbidezza rassicurante ma un buon accenno di sapidità; il Racemo Bio 2012, Frascati DOC Superiore, di Malvasia puntinata, Malvasia di Candia, Bellone e Trebbiano, sapidità minerale e struttura leggera, bouquet orientato ai fiori ed alla mineralità, a mio avviso buona capacità di reggere almeno un altro anno; infine il Tre Grome 2011 IGT Lazio Bianco, Malvasia puntinata, Malvasia rossa, Bellone. Questo è stato sicuramente il più complesso dei tre, una leggera affumicatura nel finale, ma davvero molto molto flebile, profumi di buccia d’arancia e di nocciola, mineralità al naso ed anche al palato, affiancata da una sapidità per niente fastidiosa e ben pulita dall’acidità del vino. Un bel prodotto.
La seconda cantina è La Sibilla, azienda campana all’interno dei Campi Flegrei.
Al loro banco, dove era presente anche la loro falanghina, ho assaggiato il rosato Piedirosa 2012, un piedirosso vinificato in rosato, struttura importante, acidità e mineralità come dovrebbero essere in un rosato e come raramente se ne trovano, anche di aziende famose (o soprattutto?).
Due Piedirosso, il primo un base, il secondo da vecchie vigne di 80 anni, come riportato anche in etichetta; in entrambi buon corpo, morbidezza, freschezza; aromi orientati ai fiori ed alle spezie, molto gradevole al naso. Il vecchie vigne probabilmente meriterebbe un altro paio di anni di attesa per osservarne le eventuali evoluzioni. L’ultimo assaggio di questa azienda è stato il Marsiliano, nome che deriva da uno dei vitigni autoctoni usati nel blend, profumi interessanti di ciliegia e di ribes, erbaceo, acidità piuttosto gradevole e corrispondenza con l’olfattiva. Decisamente buoni vini.
Di entrambe le aziende non so se siano bio, naturali, se usino lieviti indigeni o li vadano a comprare da qualche parte; sicuramente sono vini che mi hanno dato delle sensazioni gradevoli, non diciamo emozioni, però si sono fatti ricordare.
La delusione invece sono stati i vini di Foradori.
A parte il Manzoni bianco, semplice, fresco, buon corpo, i rossi dell’azienda soffrivano un po’ troppo di acetica alta.
Sia il Granato, che lo Sgarzon, che il Morei avevano la loro complessità completamente nascosta da un’evidente acetica che ne copriva le caratteristiche.
Queste poi venivano naturalmente fuori, i prodotti sono di alto livello come sempre, ma era necessaria una energica ossigenazione per farl svanire la nota acetica. Probabilmente l’assaggio aveva bisogno di più tempo, lasciare che il vino si acclimatasse al bicchiere, fare in modo che l’aroma pungente venisse via in modo naturale. Certo è che non ricordavo queste caratteristiche nelle precedenti annate di Foradori.