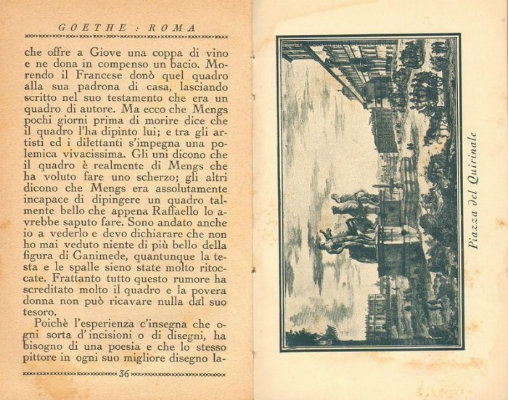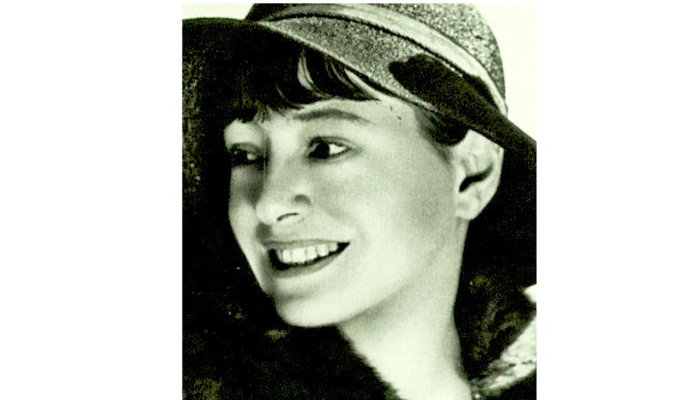Intellettuali europei, ricchi per lo più, in Italia ne sono sempre passati, qualcuno vi è rimasto anche da morto, come John Keats e Percy Shelley, entrambi sepolti nel cimitero acattolico situato a fianco della Piramide Cestia, a Roma.
L’Italia era, ma per certi versi lo è ancora, meta preferita dai cittadini europei che, se ne avevano la capacità, scrivevano resoconti dei loro viaggi.
Si viaggiava in carrozza naturalmente, il che rende ai nostri occhi moderni il viaggio più romantico, sebbene notevolmente più scomodo.
Uno dei primi a scrivere di un suo viaggio in Italia nel 1580 fu Montaigne, che però si fermò a Roma; tra gli scrittori che viaggiarono a lungo per l’Italia è d’obbligo ricordare Johann Wolfgang Goethe (1749-1832).
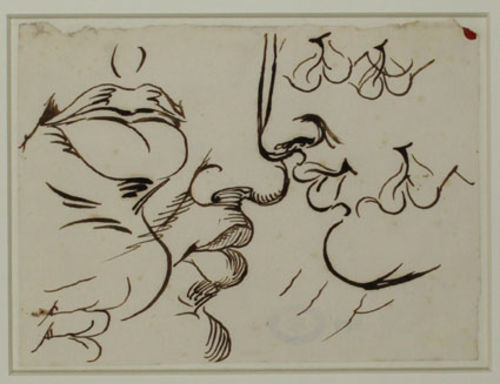
Il suo Viaggio in Italia si snoda tra il settembre del 1786 e giugno 1788, toccando praticamente tutte le città importanti d’Italia, iniziando da Trento, Verona e Venezia, passando per Ferrara e Firenze, rimanendo innamorato di Roma e Napoli e viaggiando molto per la Sicilia (“l’Italia senza la Sicilia non lascia nello spirito immagine alcuna. E’ in Sicilia che si trova la chiave di tutto”).
Roma piacque talmente allo scrittore che, tornato a Weimar, scrisse le Elegie Romane, pubblicate anch’esse come il Viaggio in Italia, molto dopo; il volume si doveva intitolare inizialmente Erotica Romana, ma ne fu cambiato il titolo in corso di stesura.
Nella XVIII elegia si trova un riferimento non solo al vino, ma anche ad una certa Faustina che comunica a Goethe l’orario dell’appuntamento scrivendolo sulla tovaglia intingendo il dito nel bicchiere di vino. Probabilmente Faustina non è mai esistita, o forse è lasciata volutamente vaga la sua figura, visto che il libro lo avrebbe letto anche sua moglie. O forse era solo un Faust sotto sembianze femminili.
Goethe è anche conosciuto per un suo celebre aforisma, quando disse che ‘la vita è troppo breve per bere vino cattivo‘, ripetuto (anche troppo) spesso nei blog e che compare in molte enoteche.
A mio parere dovrebbe essere presente soprattutto nei ristoranti, vista la cattiva scelta di vini che si trova nella gran parte di essi, almeno a Roma.
Nel suo ‘Viaggio’, il vino compare qui e là, ma non in gran misura come ci si potrebbe attendere dopo aver letto le Elegie, dove invece Goethe si mostra decisamente più carnale e desideroso di godersi la vita.
Qualche citazione però c’è.
A Trento nota che i grappoli di uva che sporgono dai muri di recinzione sono bianchi di calce; il cocchiere gli spiega che serve per evitare che i passanti possano prendere l’uva così facile da cogliere, e che in ogni caso il vino fatto con quei grappoli non ne risente.
Potrebbe essere stata uva rossa, visto che nella fermentazione della bianca le bucce non sono presenti, ed a questo punto potremmo puntare sul Marzemino che nel passato era molto presente in Trentino, coltivato a pergola.
Goethe si sofferma anche sulla condizione dei contadini delle campagne bolzanine, facendo un confronto con i loro colleghi d’oltralpe. Già il colorito dei contadini, scrive, denota uso di cibi poveri e mal cucinati, un uso smodato di polenta gialla, fatta di granturco, e verdure bollite, ma quasi mai uso di carne.
“…domandai se non c’erano anche contadini ricchi. <<Si, certamente>> <<E non si trattano bene? Non mangiano un po’ meglio?>> <<No, sono abituati così>> <<Ma che se ne fanno dei loro soldi? Quali spese hanno?>> <<Oh, anche a loro i soldi glieli ripigliano i signori>>“, questa la chiacchierata che lo scrittore ebbe con la figlia di un albergatore a Bolzano.
I vignaioli stanno anche peggio, aggiunge. Infatti nelle annate cattive, i ricchi prestano loro i soldi per riuscire a tirare avanti, soldi che si riprendono con gli interessi nelle annate buone andando a prendere il vino a pagamento del credito.
Non voglio fare paragoni con i tempi di oggi, per fortuna oggi è tutto cambiato.
Del suo soggiorno a Roma, di vino il tedesco non parla o quasi, e per la successiva citazione di un certo peso bisogna attendere il 18 aprile del 1787, durante il viaggio da Palermo verso Monreale. Un piccolo episodio, in cui si racconta che il vetturino, trovata una fonte, scese dalla carrozza per andare a riempire un botticello che Goethe credeva pieno di vino.
Quando gliene fu chiesta ragione, il guidatore della carrozza spiegò che il contenitore era pieno di vino solo per due terzi e che nessuno beve vino schietto; inoltre forse non avrebbero più incontrato altre fontane fino al loro arrivo, e che così i due liquidi avrebbero avuto tempo per mescolarsi meglio. Goethe termina il diario di quel giorno accennando “a quell’usanza nuziale dell’antico Oriente”, riferendosi alle nozze di Cana.
A settembre del 1787 lo troviamo nuovamente a Roma, nel suo viaggio di ritorno; il 22 è il giorno del suo compleanno, e lo trascorre a leggere lettere di familiari ed amici in cui gli raccontano della festa tenuta (in sua assenza!) a Weimar in suo onore, nel giardino della casa di famiglia, bevendo, come ci racconterà Schiller, del vino del Reno.
Interessante leggere che oltre le mura del Vaticano esistevano terreni coltivati a vigneto, precisamente dall’antica Porta Angelica fino al porto di Ripetta. Se fossero uve da tavola o da vino, non è naturalmente scritto; oggi sia i vigneti che la porta non esistono più, gli uni e gli altri eliminati nel 1888 durante i lavori di sistemazione urbanistica del quartiere di Borgo.
In quei giorni Goethe viaggiava molto a visitare i castelli romani, Frascati, Castel Gandolfo ed Albano. Gli era venuta l’idea di disegnare, e sicuramente non poteva trovare, almeno duecento anni fa, panorami migliori e più incontaminati.
Le zone sono naturalmente piene di vitigni e di osterie dove gustare del vino, ma il resoconto dello scrittore non ne fa cenno, forse perché vi si trova in dicembre, ed il tempo peggiora velocemente.
Il periodo è dedicato alla visita delle chiese e dei musei, dove continua la propria arte nel disegno e nel bozzetto.
Come detto all’inizio, la Italienische Reise non fu pubblicata subito, ma dopo quasi tre decenni dal viaggio: il primo volume, contenente i resoconti del viaggio fino al primo soggiorno di Roma, fu edito nel 1815, il secondo nel 1817 e l’ultimo, dedicato al secondo soggiorno romano, nel 1819.
Concludo il post con un secondo aforisma di Goethe:
Una donna ed un bicchiere di vino soddisfano ogni bisogno,
chi non beve e non bacia è peggio che morto.