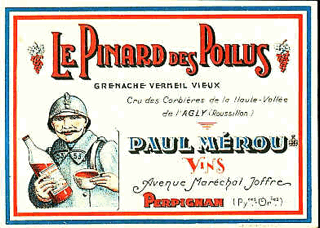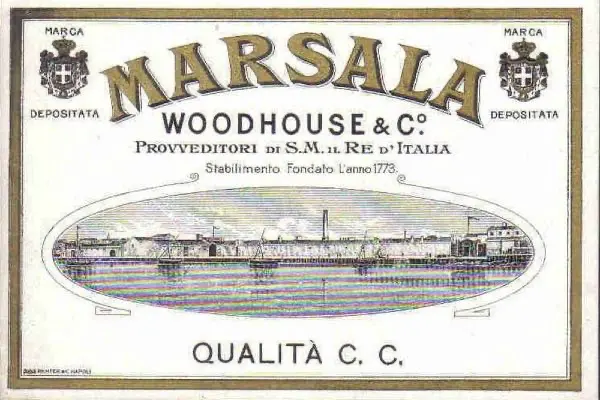Il XVIII secolo è stato un periodo di passaggio per l’Italia, e naturalmente anche per quella enologica.
La Francia era già una nazione da vari secoli, mentre l’Italia era rimasta spezzettata in possedimenti più o meno grandi di proprietà della Chiesa, dell’Austria, della Spagna e della stessa Francia, che per governare meglio il territorio avevano a loro volta suddiviso il suolo tra principati e signorotti locali.
In Francia era il secolo dei Lumi, Lavoisier, Chaptal, Pasteur, stavano svelando i misteri della natura in generale e del vino in particolare, migliorando la produttività della vigna, la fermentazione delle uve, la conservazione per lunghi anni.
Il fatto di essere una nazione unica dava chiaramente impulso ai commerci, in particolare con l’Inghilterra e con il Nuovo Mondo, spingendo i produttori a ricercare una qualità sempre maggiore, facendo nascere i Domain e gli Chateau di Bordeaux e di Borgogna.
L’Italia era stata fino al XVI secolo una grande esportatrice di vino, i mercanti veneziani portavano con le loro navi un vino delle colline veronesi prodotto “con stile greco”, e durante il Rinascimento i fiaschi di vino di Firenze erano noti in tutto il mondo civilizzato e il Lachryma Christi del Vesuvio era presente in ogni tavola reale.
Uno dei pochi che seppero valorizzare il proprio vino fu il Granduca Cosimo III di Toscana, che nel 1716 per primo regolamentò la produzione del Chianti, definendone le zone di produzione e facendo di fatto nascere il marchio del Gallo Nero.
In Toscana i vini più rinomati erano la vernaccia e l’aleatico dolce, oltre naturalmente al vinsanto, mentre il chianti veniva soprattutto venduto ai commercianti francesi che lo utilizzavano per produrre, in taglio con i vini di Borgogna, il ‘claret’, un vino leggero che piaceva molto agli inglesi.
Qualche secolo prima, nel XIV secolo, in Toscana era stato inventato il sistema del ‘governo’: dopo la vendemmia non tutta l’uva veniva pigiata e fatta fermentare, ma una piccola parte, solitamente il 10%, veniva lasciata appassire sui graticci fino ai primi di novembre, pigiata e poi aggiunta al vino, così da far ripartire la fermentazione grazie all’alta concentrazione di zuccheri presenti
In questo modo il vino prodotto aveva un carattere più morbido e gradevole rispetto alla normale vinificazione, nascondendo in parte anche gli eventuali difetti dovuti ad una non perfetta conservazione, che venivano causati sostanzialmente all’azione dell’acido acetico. Il vino che si otteneva non era adatto all’invecchiamento, ma era molto più bevibile dell’aspro chianti prodotto all’epoca. Il sistema è ancora utilizzato.
Nel XVIII secolo due stati su tutti iniziarono a risollevare le sorti enologiche della penisola italiana, la Toscana ed il Piemonte.
In Toscana il granduca Pier Leopoldo, un Asburgo degno successore dei Medici, fu il primo a tentare di affrontare la situazione.
Durante i suoi 25 anni di regno, che si conclusero con l’arrivo delle armate napoleoniche in Italia, perseguì una politica piuttosto liberale (per l’epoca), a tutto vantaggio dei commerci e dell’aristocrazia terriera. L’accademia dei Georgofili concesse a grandi proprietari come il Ridolfi ed il Ricasoli, di migliorare la propria conoscenza dell’agricoltura mettendo a disposizione i propri studiosi, sebbene lo sfruttamento dei campi rimase sostanzialmente feudale.
I grandi proprietari non avevano alcun desiderio di attuare una riforma agraria che avrebbe diminuito fortemente i propri privilegi, continuando ad usare il sistema della mezzadria per la gestione delle terre.