 Quando ero ragazzo abitavo nella periferia di Roma. Dietro casa passava la ferrovia (e ci passa ancora), e spesso il pomeriggio con un paio di amici attraversavamo i binari (DON’T TRY THIS!!!) per andare a giocare in terreni quasi completamente brulli e riarsi, dove c’era solamente terra ed un paio di alberelli sparsi. Il panorama era lunare, e per noialtri che eravamo appassionati di viaggi spaziali e fantascienza quel posto assomigliava in tutto e per tutto ad un paesaggio extraterrestre, che esploravamo con le nostre biciclette.
Quando ero ragazzo abitavo nella periferia di Roma. Dietro casa passava la ferrovia (e ci passa ancora), e spesso il pomeriggio con un paio di amici attraversavamo i binari (DON’T TRY THIS!!!) per andare a giocare in terreni quasi completamente brulli e riarsi, dove c’era solamente terra ed un paio di alberelli sparsi. Il panorama era lunare, e per noialtri che eravamo appassionati di viaggi spaziali e fantascienza quel posto assomigliava in tutto e per tutto ad un paesaggio extraterrestre, che esploravamo con le nostre biciclette.
C’era una piccola stradina in terra battuta che portava chissà dove, e l’unico che passava di là era un tale con un carretto tirato da un paio di cavalli, li ricordo sempre stanchi povere bestie, ed ansimanti; si fermava sempre allo stesso posto per abbeverare i suoi animali, visto che a pochi metri dalla strada c’era un tubo con un rubinetto che usciva dal terreno, da cui si poteva prendere acqua fresca. Probabilmente il tubo era stato messo lì dagli operai che durante il giorno lavoravano per costruire un nuovo quartiere, proprio quello dove, trent’anni dopo, sarei andato ad abitare.
Casualità della vita, che non manco mai di ricordare ai miei figli.
Il carretto non trasportava merce qualunque, avrei scoperto molti anni più avanti che era quello che viene chiamato ‘barroccio’, e conteneva cinque o sei botti impilate l’una sull’altra a piramide. Erano botti piccole, ricordo che avevano il cerchio metallico di testa di color rosso, e delle scritte sulle doghe. Il carretto è oramai sparito dalle strade di Roma, sostituito da piccoli furgoni o ‘Apette’, così come è sparito il terreno dove giocavamo agli astronauti.
A proposito, io sono un po’ più giovane della foto della breccia di Porta Pia che compare più sotto, scattata proprio nel 1870…
Vedere un barroccio per strada era però uno spettacolo comune all’epoca della foto, specialmente sulle strade di periferia percorse dagli agricoltori che portavano il proprio vino alle osterie ed ai ‘Vino e Olio’ che, ormai, son sparito pure loro.
Il quadro soprai riportato si intitola Barrocci Romani, che Giovanni Fattori dipinse nel 1872/1873, ed è attualmente custodito nella Galleria d’Arte Moderna di Firenze.
Giovani Fattori nacque a Livorno nel 1826 e muore a Firenze nel 1908. Nel 1853 frequenta Firenze dove conosce altri artisti, come Odoardo Borrani e Telemaco Signorini, a cui si unirà seguendo così le indicazioni del gruppo dei Macchiaioli.
Il suo primo viaggio a Roma è del 1873, e questo gli dà lo spunto per l’idea dei Barrocci Romani.
Il pittore riproduce proprio due di questi barrocci, con quello in primo piano che trasporta delle botti. Nel quadro si vede la strada polverosa, ed il barrocciaio stanco che si riposa, senza altra ombra che quella del suo cappello.
Il suo cavallo sellato è in piedi, mentre l’unico somaro è sdraiato. E’ tipico della pittura del Fattori rappresentare la vita quotidiana soprattutto nell’elemento della stanchezza, come militari che riposano e vegliano i feriti, o contadini sudati sotto al sole.
Il muro sembra circondare qualche possedimento o un parco, ed arriva fino in fondo al dipinto dove due platani ne segnano l’angolo; ricorda in parte il panorama dei Lancieri a Cavallo, del 1890.
 L’uomo è stanco, forse viene da Frascati dove ha riempito le botti con l’abboccato cannellino, un vino ottenuto da vendemmia tardiva di Malvasia di Candia o di Bombino, oppure dal più distante Olevano Romano, dove ha riempito le sue botti con il pregiato Cesanese. Il nostro barrocciaio, dopo il suo riposo, avrebbe controllato le funi che legavano le botti e verificato che non vi fosse qualche perdita dovuta agli scossoni del carro sulle strade malmesse e sterrate attorno alla neonata capitale d’Italia.
L’uomo è stanco, forse viene da Frascati dove ha riempito le botti con l’abboccato cannellino, un vino ottenuto da vendemmia tardiva di Malvasia di Candia o di Bombino, oppure dal più distante Olevano Romano, dove ha riempito le sue botti con il pregiato Cesanese. Il nostro barrocciaio, dopo il suo riposo, avrebbe controllato le funi che legavano le botti e verificato che non vi fosse qualche perdita dovuta agli scossoni del carro sulle strade malmesse e sterrate attorno alla neonata capitale d’Italia.
Il 20 settembre del 1870 le truppe del generale Cadorna fecero una breccia nelle mura romane all’altezza di Porta Pia, completando così l’unificazione d’Italia. L’anno successivo Roma sarebbe diventata capitale del regno al posto di Firenze.
Nel 1872, anno in cui Fattori inizia a dipingere i Barrocci Romani, muore a Pisa Giuseppe Mazzini che fu dell’Italia unita, e repubblicana, uno dei padri migliori e probabilmente più sfortunati. Nel 1871 si conclude la guerra franco-prussiana, che distolse Napoleone III dalla difesa della Roma papalina, aprendo di fatto le porte all’irruzione di Porta Pia.
E sempre nel 1871, per soli tre mesi, viene instaurata la Comune di Parigi, un governo rivoluzionario francese a cui prese parte anche Garibaldi che fu eletto nell’assemblea come deputato del dipartimento di Nizza.
L’Italia era uscita da poco dalla Terza guerra d’Indipendenza terminata con il trattato di Vienna del 1866. Era quindi l’epoca del Risorgimento, gli anni quindi in cui l’Italia cercava di affermarsi come stato unitario, seppur monarchico, ribadendo la propria indipendenza dagli altri stati europei e soprattutto dall’ingombrante presenza del Papa, Pio IX.
Garibaldi dette nome al proprio asino ‘Pionono’.
Nella viticoltura, purtroppo, erano gli anni della filossera, il parassita importato dall’America che distrusse quasi completamente il patrimonio viticolo europeo. La prima apparizione fu in Francia nel 1863, e si spostò poi rapidamente in tutto il territorio europeo arrivando in Italia nel 1879; le piante rapidamente morivano a causa della comparsa di tuberi sulle radici, che non consentivano quindi al nutrimento di arrivare fino al frutto.
Fu solamente grazie alle ricerche del professor Victor Pulliat e dalle sperimentazioni di Jules Emile Planchon che si scoprì che l’innesto delle viti europee su piede americano rendeva le viti stesse immuni al pericoloso parassita. Quindi, all’epoca dei Barrocci, le campagne romane avevano ancora i propri vitigni autoctoni originari, vitigni che in parte ritroviamo anche oggi. Il bombino, ad esempio, molto comune nel Lazio, in Emilia-Romagna e soprattutto in Puglia, è un vitigno di buona vigoria ed ottima produttività, tanto che in Emilia-Romagna viene chiamato ‘Pagadebit’ o anche ‘Stracciacambiali’, per indicare come un buon raccolto di quest’uva potesse rimettere in sesto anche le situazioni economiche più nere.
E’ presente sia bianco che nero, sebbene la varietà bianca sia quella più comune nelle campagne laziali. Non si trovano molti vini prodotti con quest’uva, segno purtroppo di come il mercato e la standardizzazione ci portino sempre più ad eliminare le varietà presenti in natura a favore di prodotti di più semplice commercializzazione.
Un altro vino che poteva essere presente dentro le botti portate dal barroccio era la Passerina, vitigno tipico della provincia di Frosinone, simile al Trebbiano toscano. Molto probabilmente però, viste le esigue dimensioni dei due carri, e soprattutto considerando che questo barrocciaio viaggiava da solo, il vino non proveniva da tanto lontano. Ed allora possiamo pensare al Nero Buono, un vino che un tempo era molto commercializzato e che oggi si trova solamente in poche produzioni originali delle campagne di Cori, a circa 50 Km da Roma.
Oppure poteva essere Bellone, vitigno a bacca bianca presente quasi esclusivamente nella zona di Roma, un vitigno molto antico e conosciuto, e citato, anche da Plinio. Dal Bellone si ricava un vino delicato, non eccessivamente profumato ed anzi quasi amarognolo, pronto da bere appena vendemmiato e quindi adatto alle osterie romane che all’epoca erano presenti praticamente ad ogni angolo di strada.
Quando scegliamo una bottiglia, cerchiamo di trovare almeno una volta un vino autoctono, un vino poco conosciuto della nostra regione, qualunque essa sia. Quel vitigno ha visto passare la storia, e senza il nostro acquisto rischierebbe di perdersi nella memoria, costringendo quei pochi produttori a dedicarsi a vitigni più remunerativi e di facile vendibilità, perdendo quindi quella diversità che rende sempre più ricco e migliore ognuno di noi.
Un bicchiere di vino scelto con cura può farci riprendere in mano quel libro di storia che abbiamo dimenticato in qualche baule, e leggere la biografia di uno degli eroi del nostro Risorgimento con la stessa attenzione che poniamo quando leggiamo l’etichetta della nostra bottiglia. In vino, veritas.


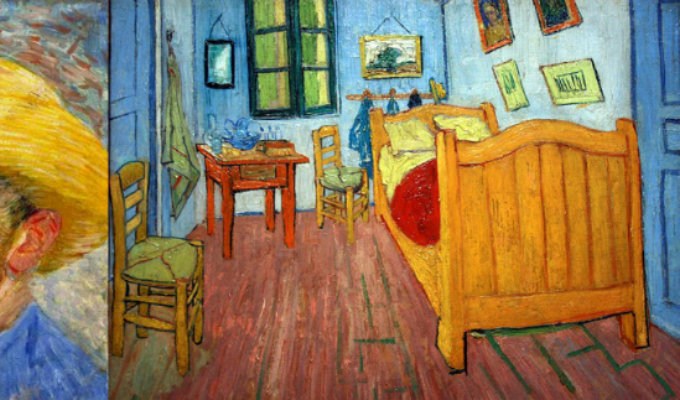



Hai la tua parte di ragione. Anch’io cerco sempre di acquistare, quantomeno nella mia regione, alcuni vini di nicchia perchè ottengo contemporaneamente il piacere di sorprendermi quasi sempre e la sensazione, nella mia coscienzza, di aiutare a dare la continuità ad un patrimonio di cultura materiale che rischia l’oblio.
Dobbiamo peraltro porgere un ringraziamento ai vignaioli che continuano a credere anch’essi nella nobile utilità di continuare a produrre questi vini di nicchia che spesso non portano gran fatturato ma la soddisfazione di continuare la tradizione. Spesso i produttori sono mossi dallo stesso sentimento che ci muove come consumatori: la curiosità per questi vini così vicini al dimenticatoio.
(Nell’indicare il mio sito web ho fatto il rimando proprio ad un post su un vino come questo).
Saluto, PO